L’hip hop in provincia
Oggi ti parlo ancora di musica. L’ho fatto nelle precedenti newsletter, quella di dicembre e di novembre, rispettivamente dedicate al concerto di Milano degli Heilung e una, più generica, sul punk (dove, tra l’altro, avevo accennato a Vivienne Westwood tra le molte cose che mi porto appresso di quel movimento e che -ahimè- avrai senz’altro saputo essere mancata alla fine del 2022).
Anche questa volta non scriverò un dotto testo di critica musicale, ma piuttosto come sia stata la colonna sonora di un periodo della mia vita e come questo abbia influenzato anche la mia produzione babaciosa.
Se il punk aveva accompagnato la mia adolescenza, il periodo successivo, la tardo-adolescenza per dirla con Enrico Brizzi*, si è svolta a tempo di hip-hop.
Il rap in Italia è definitivamente esploso solo di recente, ma in passato ha registrato due momenti di gloria, diciamo così: il primo seguiva l’affermazione del genere negli Stati Uniti e da noi ha visto i suoi massimi esponenti nei Sangue Misto (anni ’90); in seguito, grazie al fenomeno Eminem e un film che lo vedeva protagonista, in tutto il mondo si è assistito au vero e proprio revival (2002). A cavallo di questo momento incontrai alcuni ragazzi, nello sparuto paese di provincia in cui sono nata e cresciuta, che praticavano questa “arte”.
Ok, era senz’altro una cosa ancora piuttosto nuova, soprattutto in una zona a tradizione reggae (sì, lo so è strano… però sono compaesana della più famosa reggae band italiana, gli Africa Unite). Oltre alla novità, quello che più mi colpì era la modalità di espressione dell’hip hop: non solo un movimento culturale che trovava espressione in differenti campi, dalla musica al ballo, ma la possibilità di fare musica con dell’attrezzatura rudimentale e alla portata di tutti (i miei amici usavano un programma della Playstation per realizzare le basi, ma i polistrumentisti Beastie Boys pare abbiano realizzato un intero album di beat creati con un cellulare. Dell’epoca). E soprattutto m’innamorai subito dell’urgenza di comunicare, di dire le “proprie cose” e di farlo con orgoglio e decisione (loud and proud). In un panorama dove anche il rock ormai era annacquato quanto il pop, alla costante ricerca di melodie orecchiabili e testi facili, fu una vera rivoluzione; e non solo per me.
Inaccessibilità. Quel periodo ha significato però anche la difficoltà ad accedere a quella musica. Un po’ perché internet non era diffuso come oggi (ehi, non c’era ancora facebook, per dire!): io sono l’ultima generazione della mia famiglia e, come ho raccontato precedentemente, i cugini che mi hanno istruita al rock erano ancora tutti orientati all’analogico! Nessun amico nerd che mi aiutasse a scaricare musica, Napster era una specie di mostro a due teste e, comunque, la connessione era così lenta che per scaricare un singolo brano ci volevano ore. Ma poi… chi se lo filava il rap italiano?! Quand’anche uno avesse avuto accesso a un sito di file-sharing, sicuro non avrebbe trovato niente!
Tutto quello che girava, e che fosse a misura di noi giovani squattrinati, stava sui famigerati mixtape, le cassette registrate in casa con i pezzi più tosti del momento. E qui casca il secondo proverbiale asino. Eravamo in un paese di provincia, chi ascoltava quella roba lì si contava sulle dita di una mano e io, che avevo forse la testa per capire i giochi di parole e i contenuti del rap, avevo anche un grande e insormontabile ostacolo che m’impediva di essere considerata dagli altri: ero femmina.
Non stiamo a girarci intorno e indorare la pillola. Suvvia, quante donne rapper conosci? Appunto.
Possiamo anche dire che i tempi sono cambiati, ed è senz’altro così, ma stiamo parlando di un ambiente (di una cultura?) profondamente misogina. Non solo chiunque non praticasse una delle quattro auree discipline dell’hiphop (rap, breakdance, graffiti art, scratching) era apostrofato come “poser” e schifato di conseguenza… se per disgrazia nascevi femmina, be’… il tuo ruolo poteva essere solo quello della “bitch” e fare da accessorio ai baldi machi del rap. L’estetica esportata dai videoclip, che avrebbero prosperato ancora un bel po’ di anni, era quella dell’hiphop americano: gradassi pieni di gioielli e braghe larghe, attorniati da squinzie in abiti striminziti che sculettano sbattendo le ciglia (e non solo).
Oh, non che non ci fossero le eccezioni. Io poi iniziai anche a seguire (ma fu una parantesi-meteora) la scena skate del torinese e inevitabilmente caddi nel girone dantesco dello streetwear… uff, quanti soldi lasciati in quella manciata di negozi che all’epoca offrivano quelle marche!
C’è da dire che alcuni di quei capi li ho ancora nell’armadio e che li ho messi una vita, quindi -tutto sommato- rapporto qualità prezzo assolutamente imbattibile. Ma dicevamo.
Erano gli anni dell’università, quindi anche della mia uscita dalla valle, i viaggi quotidiani a Torino, sempre con le cuffie nelle orecchie, i negozi di musica della città (la prima mitica visita all’Atipici Store che stava ancora in via Nizza… questa è una chicca per i locals)… E intanto, internet che viaggiava veloce, io che prendevo a frequentare di meno i miei amici, diciamolo pure, stro**i che -in quanto femmina- inventavano scuse del ca**o per non passarmi i cd, quasi che il mio doppio cromosoma X potesse contaminare la sacra arte della doppia H.
Era un atteggiamento odioso? Certo che sì.
Mi è servito a qualcosa? Ca**o, sì!
Ho imparato che se qualcosa non te lo danno, puoi sempre prendertelo. E che fuori dalla dimensione del paesino di provincia e del quartiere cittadino, puoi sempre trovare una dimensione a tua misura. Io quel misto di cavalli (del pantalone) bassi, piercing, capelli colorati, rap, rock, scarpe cicciotte senza lacci e felpe che mi facevano stare “unfitted” in un piccolo nido valligiano, lo ritrovavo nel resto della gioventù globale… un po’ orfana del nu-metal e un po’ in fissa con la colonna sonora di 8 Mile. L’epoca in cui cominciava ad essere normale avere un filo diretto tra la propria cameretta e il mondo, un filo che prima si chiamava Myspace, poi è diventato Blogger, quindi Facebook per approdare a Youtube, Deviantart, Instagram… e tutte le diavolerie tecnologiche che ogni giorno nascono e nasceranno. È stata la rivincita di chiunque avesse qualcosa di personale da mostrare, che fosse la sua vita o la propria arte o la passione di sempre o dell’ultimo minuto. Io a quel tempo avevo già iniziato a cucire i miei pupazzetti e scoprii che potevano avere una dignità, che c’erano persone fighissime, che realizzavano cose vagamente simili e che non le chiamavano “pupazzetti” ma… rullo di tamburi… art toys. Era un cambio di prospettiva non indifferente.
Eppure ho sempre faticato a convincermi della legittimità di questo titolo. Mi è successo di recente-recentissimo, in un’operazione di rinfrescata dei miei canali di comunicazione (che è iniziata in pratica a cavallo -non basso, stavolta- tra dicembre e gennaio)… trovate ora la dicitura Art Toys in diversi posti ed è curioso -e per certi versi quasi commovente- che uno sguardo alle proprie radici a volte faccia andare a posto i tasselli giusti del puzzle della nostra identità. E che se si ha il coraggio di percorrere la propria strada con coerenza, anche nei momenti in cui ci si sente diversi da tutto il resto, senza tradire mai la nostra vera natura (fatta di gusti, inclinazioni, curiosità e talenti vari) troveremo un giorno il posto adatto per noi. Che è solo nostro, e per questo, è davvero quello giusto.
* La boomer-reference di oggi è tutta per “Jack Frusciante è uscito dal gruppo”.
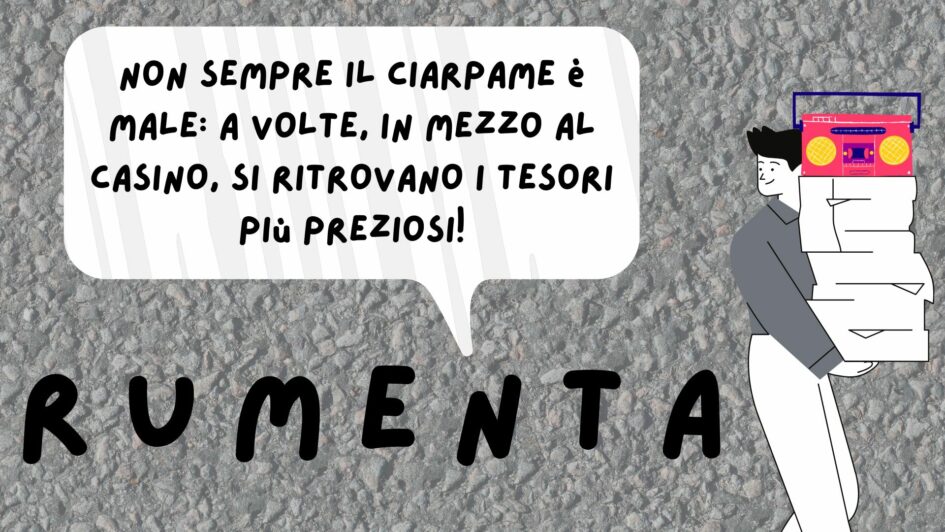
Recent Comments